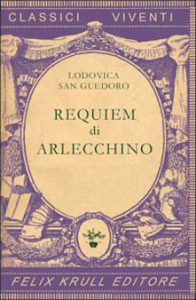 Requiem di Arlecchino (Felix Krull Editore, 2007, pp. 288) è un lucido quanto amaro reportage diaristico delle avventure/disavventure della scrittrice Lodovica San Guedoro che, partita da Monaco animata da nobili intenzioni, giunge a Roma nell’autunno del 2005 alla ricerca di registi disponibili a mettere in scena i suoi testi teatrali, ritrovandosi però travolta, molto presto, da una serie innumerevole di situazioni, di cui alcune paradossali, che la prostrano, la abbattono, che la inducono a prendere atto che tentar di farsi strada nel mondo del teatro italiano significa innanzitutto mettere a repentaglio serenità e salute, nonché doversi munire di una pazienza infinita, messa alla prova costantemente da attese interminabili e telefonate estenuanti, rincorse infruttuose, lunghe “azioni” diplomatiche intraprese per trovare ascolto, richieste di intercessione che si rivelano vane, ma significa soprattutto combattere contro “l’ottuso potere dei vecchi“, una gerontocrazia avida e prepotente il cui unico scopo nel lavoro sembra essere quello di preservare se stessa e i propri privilegi, di dispensare favori agli accoliti e ai protetti e tener buono il proprio entourage, a scapito di ogni novità, di ogni espressione di bravura e di talento, cioè del teatro stesso di cui si proclamano gli alfieri, e questo perché, detto in soldoni, “nel teatro so’ tutte lobby“, come sintetizza efficacemente l’affabile proprietario di un ristorante romano (“Sotto apparenze molli e lisce, con il carismatico alibi dell’arte, fa qui la sua macabra danza una gerontocrazia non meno prepotente di quell’altra più famosa.“).
Requiem di Arlecchino (Felix Krull Editore, 2007, pp. 288) è un lucido quanto amaro reportage diaristico delle avventure/disavventure della scrittrice Lodovica San Guedoro che, partita da Monaco animata da nobili intenzioni, giunge a Roma nell’autunno del 2005 alla ricerca di registi disponibili a mettere in scena i suoi testi teatrali, ritrovandosi però travolta, molto presto, da una serie innumerevole di situazioni, di cui alcune paradossali, che la prostrano, la abbattono, che la inducono a prendere atto che tentar di farsi strada nel mondo del teatro italiano significa innanzitutto mettere a repentaglio serenità e salute, nonché doversi munire di una pazienza infinita, messa alla prova costantemente da attese interminabili e telefonate estenuanti, rincorse infruttuose, lunghe “azioni” diplomatiche intraprese per trovare ascolto, richieste di intercessione che si rivelano vane, ma significa soprattutto combattere contro “l’ottuso potere dei vecchi“, una gerontocrazia avida e prepotente il cui unico scopo nel lavoro sembra essere quello di preservare se stessa e i propri privilegi, di dispensare favori agli accoliti e ai protetti e tener buono il proprio entourage, a scapito di ogni novità, di ogni espressione di bravura e di talento, cioè del teatro stesso di cui si proclamano gli alfieri, e questo perché, detto in soldoni, “nel teatro so’ tutte lobby“, come sintetizza efficacemente l’affabile proprietario di un ristorante romano (“Sotto apparenze molli e lisce, con il carismatico alibi dell’arte, fa qui la sua macabra danza una gerontocrazia non meno prepotente di quell’altra più famosa.“).
Brillano in queste pagine, di forte luce propria, lo spirito di iniziativa e la verve dell’autrice: è lodevole infatti come Lodovica San Guedoro in tale lotta impari, che la vede purtroppo soccombere, non si risparmi in alcun modo ma metta in gioco tutta se stessa, nella vita come nelle opere. Spinta da un’energia incredibile, come mossa da un sacro demone, dal desiderio autentico di veder realizzati i propri sogni, non si sottrae dal confidarci il suo entusiasmo, gli slanci emotivi, le speranze subito ridimensionate dagli eventi, dai dinieghi (“Due falle apertesi quasi contemporaneamente nella mia valorosa imbarcazione, silurata da vili sommergibili striscianti subdolamente sui fondali marini.“), così come il suo triste scoramento, l’afflizione dovuta alle meschinità e all’ipocrisia (“Del resto la sincerità risulta quasi sempre inappropriata in questo mondo.“), ai voltafaccia improvvisi di chi promette e poi si sfila accampando scuse, alle menzogne di un mondo in cui tutti paiono gentili e disponibili ma in cui è difficile distinguere il vero dal falso, restando sempre sorretta però – e anche in questo non possiamo che essere dalla sua parte, – dalla convinzione che “l’arte vera deve essere favorita, sostenuta, aiutata, non abbandonata a se stessa come fa lei, defraudando in uno gli autori e il mondo. E più che mai oggi che ce n’è così poca in giro.” come lei stessa ebbe a scrivere a Ronconi in una lettera.
Colpisce allora la franchezza, questo suo raccontare e raccontarsi mostrandosi così come è, senza mai edulcorare su di sè o sugli altri, senza risparmiare sferzate acute, a destra e a manca, ma colpendo di santa ragione, e accompagnando ogni episodio di questa sua discesa in Italia con analisi mirabilmente feroci, forte di un’ironia sottile e dissacrante che mette a nudo doppiezze ed insincerità, sconfessando così editori e registi onnipotenti, la cosiddetta “cultura eletta”, riportata in questo modo coi piedi per terra (“Non avevo affatto bisogno di vederla, questa tragedia del Polesine riscovata: ad occhi chiusi inquadravo il pezzo, col suo stile monologante senza forma e senza stile e la sua psicologia ovvia e scontata, nella categoria di quel teatro ancor più catastrofico e noioso perché senza catarsi e senza un briciolo di estetica. Inoltre, si trattava di un pezzo nato su commissione dello Stato (che provoca le calamità), affinché qualche assessore e qualche direttore di teatro potessero pavoneggiarsi di aver speso soldi in direzione dell’impegno. “Teatro civile”, viene poi chiamato, questo . No, grazie.“).
Ne risulta quindi, a lettura ultimata, un testo essenziale per conoscere la condizione del teatro nell’Italia contemporanea, non di quello che si mette in mostra sulla scena, sui palcoscenici di provincia o della capitale, ma di quello che prende vita e prolifera dietro le quinte, di cui l’autrice riporta aneddoti e curiosità, luci e ombre, consegnandoci alfine dei ritratti emblematici, da cui si evince tutta la grande varietà della “civiltà” italica, con i suoi tic, le sue meschinità, con il suo rivelarsi “piccola” a conti fatti, di sicuro interesse per un antropologo.
È insomma, a ben vedere, la metafora più appropriata per raccontare la morte del teatro italiano (“È un uomo vestito da Arlecchino!” “E’ morto…” constata quasi nello stesso istante un medico accorso, levandogli la maschera. “Oh, che bel giovane!” esclama sospirando una spettatrice di seconda fila. Ora Aricò è in lacrime. Ha avuto il compito di identificarlo e, ahimè, lo ha, con quanta amarezza!, fatto: era proprio Arlecchino, il precipitato, non uno travestito: l’ultimo artigiano addetto al cambiamento delle scene!“) e con essa la fine del bello, del nuovo, di ogni estro creativo, sopraffatti impunemente dal mercimonio, dai favori, dai piaceri elargiti agli amici, dagli interessi osceni del politicante di turno, da tante ignobili bassezze che poco avrebbero a che fare con questo mondo, in cui chi fa la sua comparsa deve disgraziatamente aspettare il proprio turno e non può stravolgere, nonostante il talento, posizioni e gerarchie consolidate, salvo apparire molesto e inopportuno.
È il ritratto di un Paese che, sopravvissuto senza merito al suo glorioso passato, è purtroppo una realtà palesemente feudale, in cui vige tuttora uno stato di servaggio, in cui è ormai prassi collaudata che sia la mediocrità ad avere la meglio, anche grazie alle elargizioni di Stato (“Sennò alla mediocrità chi ci pensa?”, disse qualcuno in una intervista), e questo a scapito dei più bravi, travolti ingiustamente e inesorabilmente dalla stessa fredda ostilità che ha colpito l’autrice, il cui destino sembra essere tracciato, ma solo per il momento, nell’epigrafe che precede il libro: “Ed essi, che erano suoi fratelli e dovevano aiutare la loro sorella, pur potendo, non vollero far nulla, non dissero una parola: e così lei andò errando esule, mendica, in terra straniera, sempre…”.
#lodovicasanguedoro #requiemdiarlecchino #FelixKrull #recensione
Recensione apparsa su Lankenauta.